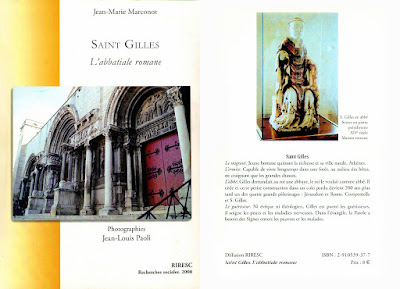«C’è crisi. Nonostante il suo ottimismo
di fondo, Kahnweiler era preparato. Ormai la si deve affrontare. Il 25 ottobre
1929, la borsa di New York crolla secondo uno schema tutto sommato banale,
poiché lo riscontriamo nella crisi che ha colpito la Francia nel 1882 e in
quella degli Stati Uniti del 1907. Ma questa sarà più lunga e più ampia.
Si prospettano anni di vacche magre. Il cosiddetto commercio
del lusso, qual è il mercato dell’arte, come potrà non soffrirne? ... Kahnweiler ha
la sgradevole impressione che niente valga più niente. Nessuno compera. ... Tutti
sono nella stessa barca. Ogni tanto il morale risale. Si parla di una leggera
ripresa. ... Kahnweiler esprime queste opinioni nelle lettere al cognato Michel
Leiris che sta percorrendo l’Africa come segretario-archivista della missione
Dakar-Gibuti. Anche le opinioni di quest’ultimo sulla crisi, vista da Dakar o
da Yaoundé, sono interessanti: “Ho una gran fretta di essere nella savana, lontano dagli europei imbecilli e dai negri truccati. ... Vista da lontano la situazione europea mi
sembra più che mai insensata. In ogni caso essa costituisce la prova più
schiacciante dell’inutilità della nostra civiltà”.
Alla galleria ci si annoia a morte. È un
deserto. ... Fra il 1929 e il 1933 la galleria Simon non organizza neppure una
mostra. Anche l’attività editoriale è considerevolmente ridotta: escono solo le
poesie di Carl Einstein e L’anus
solaire di Georges Bataille. Gli altri
aspetteranno. Non si può ingozzare un pubblico restio.»
Pierre Assouline. Il mercante di Picasso
Traduzione dal francese
di Nanda Torcellan
Garzanti Editore 1990, pp
275-277
Certo, sono anni
difficili, aiutati dalla vecchia regola della coperta corta: se la massa ha i
piedi al freddo è perché pochi hanno le spalle al caldo. Le gallerie d’arte
cercano di sopravvivere e le loro attività collaterali, quali l’edizione di
libri da collezione, boccheggiano per mancanza d’ossigeno.
È proprio in questo momento storico che un ricco
mercante di quadri, Ambroise Vollard, lancia il guanto e sfida il destino - e
qui mi fermo per fare un balzo indietro nel tempo di cent’anni, quando il 31
luglio e il 7 agosto 1831 il periodico L’artiste pubblica Le
chef-d’œuvre inconnu di Honoré de Balzac,
che inizia così:
Vers la fin
de l’année 1612, par une froide matinée de décembre, un jeune homme dont le costume était de très-mince apparence, entra dans une maison de la rue des Grands-Augustins, ...&tc. &tc.
Ritorno all’anno 1931.
Come detto sopra, la crisi morde i polpacci ai poveri e al ceto medio, ma non
sono queste masse ad aver reso ricco Vollard. Il mercato ristagna, è vero, ma
lui, che ama il rischio (calcolato), chiede a Picasso se ha dei disegni utili ad
illustrare una nuova edizione de Le
chef-d’œuvre inconnu di Balzac, tirata in poche copie e in grande formato.
Roba di lusso, per collezionisti ricchi.
Scrive Patrick O’Brian
in Picasso (pp. 320-321), una
biografia già citata in altri miei post:
Un artista al lavoro, talvolta un
pittore, talaltra uno scultore, spesso con una modella, fa ora la sua comparsa
tra i personaggi di Picasso: una figura che ritroveremo spesso nei suoi quadri,
in varie forme, mai però ispirata a un sentimento di autostima.
Spesso si tratta di un uomo tarchiato,
con barba, abbastanza «classico» non fosse per i calzoncini corti, dall’aria
sbalordita se non stupida, quale a volte può avere un toro; in una delle prime
acqueforti l’uomo è seduto davanti al cavalletto e fissa attentamente la
modella o qualcosa attraverso di lei; intanto con la destra traccia una
mirabile serie di curve e di piani rettilinei che non sembrano avere molta
attinenza con la donna: costei, d’aspetto gradevole, di mezz’età, lavora a
maglia in grembiule ed è disegnata, al pari dell’uomo, con il perfetto realismo
descrittivo che Picasso, quando voleva, sapeva produrre.
Sarebbe interessante sapere se l’acquaforte
fu eseguita prima che Vollard parlasse a Picasso della sua intenzione di
realizzare un’edizione illustrata del Chef
d’oeuvre inconnu di Balzac, poiché il
libro narra di un pittore il cui capolavoro non può essere capito da nessuno se
non dal suo stesso autore, ma in proposito gli studiosi hanno pareri
contrastanti e anche i ricordi di Vollard sono vaghi. Altrettanto interessante
sarebbe sapere se Picasso avesse letto il romanzo o no. Dalla descrizione che
ne fece a Geneviève Laporte molti anni più tardi sembrerebbe di no, eppure
poche opere gli sarebbero maggiormente piaciute. Molto succintamente la storia,
ambientata nel 1612, è questa: il giovane Nicolas Poussin va a trovare il noto
pittore Pourbus in Rue des Grands-Augustins e, dopo qualche esitazione, entra
nello stesso istante in cui sopraggiunge anche un ricco signore anziano, di nome
Frenhofer: Frenhofer critica il lavoro di Pourbus con grande libertà,
esprimendo alcune opinioni molto interessanti in fatto di pittura. Poussin,
sconosciuto a entrambi, si intromette ed è riconosciuto da ambedue quale un
vero artista. Pourbus è gentile con il giovane, lo incita a lavorare, gli dice
che Frenhofer era stato allievo di Mabuse e che adesso è pittore dilettante
giacché, essendo ricco, non è obbligato a vendere, ma capace al punto che
Pourbus ha scambiato i suoi dipinti per quelli di Giorgione. L’amicizia si fa
più stretta, grazie anche al fatto che Poussin ha una giovane amante molto
bella («una di quelle anime nobili e generose capaci di soffrire accanto a un
grand’uomo, condividendone angosce e difficoltà e facendo tutto il possibile
per comprenderne gli umori, sopportando l’indigenza e attingendo forza all’amore»),
una donna che a Frenhofer piacerebbe avere come modella. Un giorno si trovano
tutti nello studio di Frenhofer, dove Poussin vede alcuni quadri di mirabile
fattura, che tuttavia Frenhofer giudica di poco conto a paragone del suo
capolavoro, un dipinto che egli è estremamente riluttante a mostrare; infine si
decide e lo fa vedere agli amici. Poussin non riesce a capire nulla in quel
caos di colori, in quelle «gradazioni incerte, in quella specie di bruma
informe», tranne «un solo piede, vivo e squisito». Dice però che non riesce a
distinguere alcuna figura femminile nel dipinto. Frenhofer piange, per un
attimo cerca di confortarsi immaginando che i due siano ladri, ma finisce per
bruciare il quadro quella stessa notte, e muore.
Nel 1931, quando finalmente fu
pubblicato, il libro conteneva acqueforti e disegni di Picasso puntiformi e
cubisti, certamente precedenti all’idea del libro, oltre a qualche acquaforte
realizzata per l’occasione; in tutto ottanta illustrazioni.
Sebbene Picasso abbia scelto le incisioni “a naso”, l’unità dell’opera non
ne esce alterata. Il successo di critica e di vendita premiano il coraggio dell’editore.
Potrei fermarmi qui, se
non fosse che il bello è ancora da venire.
Siamo ai primi giorni
di gennaio del 1937 e Picasso, privato del grande studio di Boisgeloup che il
tribunale ha assegnato a sua moglie Olga, da cui si è separato, cerca una nuova
sistemazione per lavorare. Gli viene incontro Vollard che gli affitta una
vecchia casa da lui comperata a Le Tremblay-sur-Mauldre, col granaio
trasformato in studio; come abitazione, a Parigi il pittore mantiene i due
piani acquistati in Rue La Boëtie, mentre la sua nuova fiamma, Dora Markovich - in arte Dora Maar - vive
in un appartamento in Rue de Savoie, vicinissimo al complesso di studi che
Picasso ha preso in affitto da alcuni anni, ma che finora ha poco o nulla
frequentato.
Lo fa verso la fine di
marzo, quando decide di occupare saltuariamente i due piani della vecchia casa
del Settecento al n. 7 di Rue des Grands-Augustins, chiamata il “granaio
Barrault” dal nome del vecchio inquilino - e il caso vuole che questa fosse
proprio la casa in cui Balzac aveva ambientato Le chef-d’œuvre inconnu,
una storia che ruota attorno a un pittore ...cubista.
Poche settimane dopo,
il 26 aprile, la città di Guernica è distrutta dai bombardieri tedeschi, ma la
notizia arriva a Parigi il 28. Nello studio di Rue des Grands-Augustins il
primo maggio Picasso esegue i primi cinque schizzi preparatori della tela che a
giugno sarà esposta al Padiglione spagnolo dell’Esposizione Internazionale di
Parigi, da allora nota col nome della città martire, Guernica.
Ma è solo nel mese di
giugno del 1939 che Picasso si insedia definitivamente al numero 7 di Rue des
Grands-Augustins, seppur continuando a conservare l’appartamento di Rue de la
Boëtie, dove lascia parte delle sue pitture. Per l’occasione, l’artista decide
di far mettere il riscaldamento centrale per rendere abitabili i due piani
dell’ex granaio Barrault. Decide anche di impiantare in casa un laboratorio
d’incisione e fa venire da Boisgeloup il vecchio torchio e tutto il materiale
necessario. Verso la fine di giugno ogni lavoro è terminato e Picasso può
iniziare la sua ennesima vita, entusiasmando Vollard con i suoi progetti di
stampe per edizioni future. Purtroppo il sogno di Vollard è di breve durata: il
21 luglio, a causa di incidente d’auto, muore dopo essere stato colpito alla
nuca da una pesante scultura di Maillol che stava trasportando.
Anno 1940, anno di guerra.
Picasso continua ad abitare in Rue La Boëtie, ma i tragitti tra la casa e lo
studio divengono difficili. Decide così di trasferire la residenza in Rue des
Grands-Augustins, installandovi una camera da letto. Per i pasti, capita spesso
in un ristorante che porta un nome suggestivo, Le Catalan - 25, Rue des Grands-Augustins. Ed è qui che una sera di
maggio del 1942, mentre sta cenando con Dora Maar, Marie-Laure de Noailles e
altri amici, nota due giovani belle donne sedute a un tavolo in compagnia di
Cuny, un attore allora in auge. Dopo le presentazioni e scambiata qualche battuta
Picasso invita le ragazze a fargli visita nella sua casa-studio e molti anni
dopo una delle due, Françoise Gilot, scriverà nelle sue acide memorie (pp
12-15):
Il lunedì seguente, verso le undici,
Geneviève e io ci arrampicavamo per una buia e stretta scala a chiocciola,
nascosta nell’angolo del cortile acciottolato del numero sette di rue des
Grands-Augustins, e bussavamo alla porta dell’appartamento di Picasso. Dopo una
breve attesa, la porta si aprì di pochi centimetri per rivelare il naso lungo e
sottile del suo segretario, Jaime Sabartés. Non l’avevamo mai incontrato prima
di allora, ma sapevamo chi era. Avevamo visto riproduzioni dei disegni che
Picasso gli aveva fatto e Cuny inoltre ci aveva avvertito che sarebbe stato lui
ad accoglierci. Ci guardò con aria sospettosa e chiese: «Avete un
appuntamento?» Risposi affermativamente. Ci lasciò entrare. Aveva un aspetto
inquieto e ci scrutava dietro le spesse lenti.
Entrammo in un vestibolo pieno di
uccelli - c’erano delle tortore e un certo numero di uccelli esotici dentro a
gabbie di vimini - e di piante. Le piante non erano belle; verdi e spinose come
se ne vede spesso nei vasi di rame delle portinerie. Là invece erano disposte
in un modo più attraente, e facevano un bell’effetto di fronte alla finestra
spalancata. Avevo visto una di quelle piante un mese prima, in un ritratto
recente di Dora Maar, esposto, a dispetto dei nazisti che avevano messo al
bando le opere di Picasso, in un angolo della galleria di Louise Leiris, in rue
d’Astorg. Era un magnifico ritratto in rosa e grigio. Sul fondo della tela c’era
una vetrata a piccoli riquadri, che riconobbi nella vecchia e grande finestra,
una gabbia d’uccelli e una di quelle piante verdi.
Seguimmo Sabartés in una seconda stanza,
molto lunga. Disposti su vecchi divani e su sedie Luigi XIII si trovavano
chitarre, mandolini ed altri strumenti musicali che pensai Picasso avesse usato
per i suoi quadri del periodo cubista. Egli mi raccontò più tardi che aveva
acquistato quegli strumenti dopo aver dipinto i quadri, non prima, e che li
conservava a ricordo degli anni del Cubismo. La stanza era bella e ampia, ma vi
regnava un disordine indescrivibile. La lunga tavola che si stendeva fino a noi
e due banchi da falegname, uno a prolungamento dell’altro, ridosso alla parete
di destra, erano coperti da pile di libri, di riviste, di quotidiani, di
fotografie, di cappelli e di oggetti di vario genere. Sopra uno di questi
banchi era posato un pezzo di cristallo grezzo d’ametista, grande quanto una
testa umana. Al centro di questo blocco c’era una piccola cavità, totalmente
chiusa, piena di qualcosa che sembrava acqua. In un ripiano sotto al tavolo si
trovavano una pila di vestiti da uomo e tre o quattro paia di scarpe.
Mentre costeggiavamo la grande tavola
centrale, notai che Sabartés girava attorno a un oggetto di color bruno scuro,
posato sul pavimento, vicino alla porta che dava nella stanza accanto. Quando
mi avvicinai, mi accorsi che si trattava di una scultura: un cranio in bronzo.
La stanza successiva era uno studio
quasi totalmente stipato di sculture. Vidi così L’uomo col montone,
ora fuso in bronzo e collocato nella piazza del mercato di Vallauris, e che, a
quel tempo, era semplicemente di gesso. C’erano inoltre numerose grandi teste
di donna che Picasso aveva eseguito a Boisgeloup, nel 1932, un ammasso di
manubri di bicicletta, rotoli di tele, un Cristo spagnolo di legno policromo
del XV secolo, e una bizzarra e affusolata scultura, rappresentante una donna
che teneva in una mano una mela e nell’altro braccio qualche cosa che
assomigliava a una borsa dell’acqua calda.
La cosa più sorprendente, tuttavia, era
costituita da uno squillante Matisse, una natura morta del 1912, che
rappresentava una fruttiera piena d’arance posata sopra una tovaglia rosa e
contro un fondo oltremare e color rosa di Tiro. Ricordo anche un Vuillard, un
Doganiere Rousseau e un Modigliani; ma in quello studio avvolto d’ombra, lo
splendore del Matisse squillava fra le sculture. Non potei trattenermi dall’esclamare:
«Oh, che bel Matisse!» Sabartés si volse e disse, austero: «Qui non c’è che
Picasso!»
Per un’altra scaletta a chiocciola, all’estremità
della stanza, salimmo al secondo piano dell’appartamento di Picasso. Là il
soffitto era molto più basso. Passammo in un grande studio. Sul fondo,
circondato da sette od otto persone, scorsi Picasso. Indossava un vecchio paio
di pantaloni che gli stavano larghi e una maglia da marinaio a righe bianche e
blu. Quando ci vide il suo volto si illuminò di un sorriso. Lasciò il gruppo e
ci venne incontro. Sabartés brontolò qualcosa circa il nostro appuntamento e
scomparve.
«Volete vedere lo studio?» chiese
Picasso. Rispondemmo di sì. Speravamo che ci mostrasse dei quadri, ma non
osavamo chiederlo. Ci ricondusse al piano inferiore, nello studio di scultura.
«Prima che m’installassi qui,» disse,
«questo primo piano era il laboratorio di un tessitore, quello di sopra, lo
studio di Jean-Louis Barrault. In questa stanza ho dipinto Guernica.» Si era
seduto su una tavola Luigi XIII, davanti alle finestre che davano sul cortile
interno. «A parte questo, non lavoro quasi mai in questa stanza. Ho scolpito
qui L’homme au mouton,» disse indicando il grande gesso dell’uomo
che tiene fra le braccia la pecora, «ma dipingo lassù e, di solito, eseguo le
sculture in un altro studio che si trova poco più avanti su questa strada. «La
scala a chiocciola che avete preso per venir qui è quella che il giovane
pittore de Le chef-d’œuvre inconnu di Balzac saliva per andar a trovare il
vecchio Pourbus, l’amico di Poussin che dipingeva tele non comprese da nessuno.
Oh, tutto il luogo è ricco di fantasmi storici e letterari. Bene, torniamo su.»
Scivolò giù dalla tavola e lo seguimmo per la scaletta a chiocciola. Ci
condusse attraverso il grande studio, attorno al gruppo dei visitatori, nessuno
dei quali alzò la testa al nostro passaggio, fino a una piccola stanza, proprio
in fondo.
«Qui lavoro alle mie incisioni,» disse.
«Guardate qui.» Si diresse verso l’acquaio e aprì il rubinetto. Dopo un po’ l’acqua
prese a fumare. «Meraviglioso, vero? Nonostante la guerra ho l’acqua calda. Del
resto,» aggiunse, «potete venire a fare il bagno quando volete.» Ma non era l’acqua
calda che ci interessava, nonostante che allora fosse scarsa. Guardando
Geneviève pensai: «La smettesse di parlare dell’acqua calda e ci facesse vedere
almeno dei quadri!» Invece cominciò a tenerci un piccolo corso sulla tecnica
dell’acquaforte e stavo proprio pensando che con tutta probabilità ce ne
saremmo dovute andare senza vedere alcuna delle sue opere e che non saremmo mai
più ritornate, quando, finalmente, ci condusse nel grande studio e ci mostrò
alcuni quadri. Ricordo un gallo, ricco di colore e forte nell’impostazione, che
lanciava un vigoroso chicchirichì. Ricordo anche un altro quadro, dello stesso
periodo, molto rigoroso e tutto in bianco e nero.
Verso l’una, il gruppo dei visitatori ci
lasciò e ciascuno prese congedo.
Ciò che mi colpì in modo curioso fin da
quel primo giorno fu il fatto che lo studio sembrava il tempio di una specie di
«religione picassiana», e che tutti i presenti apparivano completamente immersi
in quel culto - tutti, eccetto quell’uno cui quell’attenzione era rivolta. Egli
sembrava prender tutto per scontato, senza dare importanza a nulla in
particolare come se volesse mostrarci che non intendeva affatto essere al
centro di un culto.
Mentre ci apprestavamo ad andarcene,
Picasso ci disse: «Se volete ritornare, fatelo. Ma non come pellegrini che vanno
alla Mecca. Venite perché trovate interessante la mia compagnia e perché volete
avere con me uno scambio semplice e diretto. Se volete vedere soltanto i miei
quadri, potete benissimo andare in un museo.»
Non presi troppo seriamente quest’osservazione.
Prima di tutto perché a quel tempo non c’era quasi alcun Picasso nei musei
parigini. Secondo, perché egli si trovava nella lista dei pittori proibiti dai
nazisti e nessuna delle gallerie private poteva esporre apertamente le sue
opere e in una certa quantità. E a un pittore non basta vedere le opere di un
altro pittore riprodotte in un libro. Per conoscere meglio i suoi lavori, ed
era il mio caso, la cosa più semplice era di recarsi al numero 7 di rue des
Grands-Augustins.
Per essere la prima
visita, i fin troppo precisi dettagli rendono poco credibile questo racconto.
Comunque sia, per alcuni anni i due si frequentano come amici, finché, scrive
ancora la Gilot, «una sera sul presto, verso la fine di maggio 1946, mentre
mi preparavo a lasciare Rue des Grands Augustins per tornare dalla nonna, Pablo
ricominciò a insistere … e rimasi lì, senza dire addio e senza dare una spiegazione
a nessuno … Non uscii di casa per un mese intero dal giorno in cui ero andata a
vivere con Pablo.»
Risultato:
da questa relazione il 15 maggio 1947 nasce un figlio, Claude. Il mese dopo la
famiglia si sposta al Sud, a Golfe-Juan, dove abitano la casetta di Louis Fort.
Nell’autunno Picasso comincia a lavorare nella fabbrica Madoura di Vallauris
condotta dagli amici Ramié: un nuovo amore, una nuova casa è la costante di
Picasso.
 |
Françoise Gilot e Pablo Picasso
by Robert Doisneau, 1952 |
Gran finale. A Milano,
sotto i portici di piazza Diaz, una volta al mese si tiene una ricca fiera del
libro usato. Domenica scorsa, 14 giugno 2015, vengo attratto da una custodia
marroncina, quadrata. La prendo, sfilo il libro e che mi ritrovo tra le mani?
La riedizione de Le chef-d’œuvre inconnu curata nel 1966 dalle Éditions
L.C.L. Il colophon recita (in francese, qui da me tradotto): Questo
volume della collezione «Les Peintres du Livre» composto in carattere Bodoni
corpo 18 è stato tirato dallo stampatore Firmin-Didot, Parigi - Mesnil - Ivry
su carta Blanchemer delle Papeteries Prioux. La stampa delle illustrazioni è
stata curata dall’Imprimerie Genése di Parigi. La rilegatura è stata realizzata
da Bonnet-Madin a Dreux. La tiratura è stata limitata a 3000 esemplari numerati
da 1 a 3000 e a 50 esemplari fuori commercio marcati H. C. destinati ai
fondatori e ai collaboratori della collana.
Questa copia porta il
numero 1490. Dentro vi sono le incisioni di Picasso, mentre il Pittore
osservato dalla modella nuda è stampato e inserito a parte, su cartoncino
bianco, fuori dal libro.
Domando: «Quanto chiede
per questo libro?».
«Dieci euro.»
È in casa.
Racconto inserito lo stesso anno 1831 nel terzo tomo dei
Romans et contes philosophiques par
M. Balzac, Paris, Charles Gosselin Libraire, poi ripubblicato con leggere modifiche
nel 1847 col titolo Gillette ne Le provincial à Paris par H. de Balzac,
Paris, Gabriel Roux et Cassanet Éditeur.